| Roma,
fino dai primi anni della sua origine, per limitare il danno
degli incendi ed ostacolare il loro propagarsi,
stabilì che le abitazioni sorgessero distaccate le une dalle
altre. 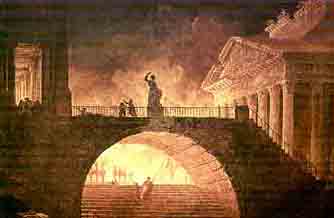 Tale
disposizione col trascorrere degli anni e col crescere della popolazione
andò in disuso e ben presto si ebbero veri e propri quartieri
con agglomerazioni di case di
tre
o quattro
piani ("Insulae")
costruite in gran parte con strutture in legname, vicine a magazzini
di merci e di cereali, separati da strade strette e tortuose in
cui venivano costipate e compresse numerose famiglie. Tale
disposizione col trascorrere degli anni e col crescere della popolazione
andò in disuso e ben presto si ebbero veri e propri quartieri
con agglomerazioni di case di
tre
o quattro
piani ("Insulae")
costruite in gran parte con strutture in legname, vicine a magazzini
di merci e di cereali, separati da strade strette e tortuose in
cui venivano costipate e compresse numerose famiglie.
Alla
presenza di materiali facilmente infiammabili si aggiungeva,
nei luoghi dei sinistri, la costante mancanza di acqua, nonostante la
presenza in città di diversi e maestosi acquedotti, che ve ne
portavano grandi quantità. Non esistevano, infatti, colonne montanti
di acqua che la portassero oltre il piano terreno e quando un incendio
scoppiava a quei livelli era molto difficile che pochi orci o catini
potessero bastare a domarlo.
Di
questa situazione ci parla anche Giovenale in una delle sue satire:
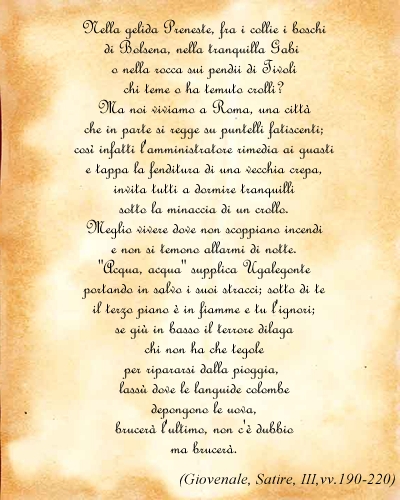
Si
ebbero così frequenti e gravi incendi. Tra questi
grandi roghi, che  culmineranno
nel famoso e catastrofico incendio sviluppatosi nell'anno 64 d.C. sotto
l'imperatore Nerone (54-68
d.C.) e
nell'altro non meno distruttivo, avutosi durante il principato di Commodo
(128-195 d.C.), la vita a Roma era un fiammeggiare quotidiano di roghi
minori. culmineranno
nel famoso e catastrofico incendio sviluppatosi nell'anno 64 d.C. sotto
l'imperatore Nerone (54-68
d.C.) e
nell'altro non meno distruttivo, avutosi durante il principato di Commodo
(128-195 d.C.), la vita a Roma era un fiammeggiare quotidiano di roghi
minori.
Tutte queste concause indussero i romani a istituire
la prima organizzazione per prevenire e combattere gli incendi con la
istituzione dei Triunviri nocturni
o capitoles che vigilavano durante la notte
i pericoli del fuoco avendo a loro disposizione una compagnia di schiavi
famiglia pubblica, dislocata lungo le mura
della città e presso le porte, alla quale spesso si aggiungevano
famiglie privatae organizzate dai cittadini
e che accorrevano prestando l'opera loro gratuitamente o a pagamento.
I triunviri nocturni nell'anno 289 a.C. divennero
veri e propri Magistrati.
|
L'Imperatore
Cesare Ottaviano Augusto nel riordinamento generale
dei servizi pubblici  (anno
6 d.C.) comprese anche quello relativo allo spegnimento degli incendi
con la istituzione della Militia Vigilum,
forte di 7000 uomini agli ardini di un capo supremo Praefectus
vigilum, personaggio dell'ordine equestre, di carattere
militare, con giurisdizione civile e penale, coadiuvato da un luogotenente
col titolo Subraefectus. (anno
6 d.C.) comprese anche quello relativo allo spegnimento degli incendi
con la istituzione della Militia Vigilum,
forte di 7000 uomini agli ardini di un capo supremo Praefectus
vigilum, personaggio dell'ordine equestre, di carattere
militare, con giurisdizione civile e penale, coadiuvato da un luogotenente
col titolo Subraefectus.
Tanto il Prefetto quanto il Sottoprefetto dei vigili avevano a loro
disposizione dei Segretari (commentarieuses)
per la redazione del diario del Corpo, dei sottufficiali (corniculorius)
e delle ordinanze (beneficiari).
Questa Milizia ebbe il duplice incarico della prevenzione e spegnimento
degli incendi e del mantenimento della sicurezza della città.
I
7000 uomini erano raggruppati in 7 coorti, (VII  Cohortes
vigilum), acquartierate in sette caserme chiamate Castra
e in sette posti di guardia chiamati Excubitoria,
in modo che ciascuna delle XIV regioni, nelle quali era divisa la città,
aveva un posto di soccorso; in tal modo i Romani fino dall'anno 6 dopo
Cristo avevano adottato il decentramento dei servizi di soccorso per
ridurre al minimo lo spazio di tempo necessario per iniziare lo spegnimento
degli incendi. Cohortes
vigilum), acquartierate in sette caserme chiamate Castra
e in sette posti di guardia chiamati Excubitoria,
in modo che ciascuna delle XIV regioni, nelle quali era divisa la città,
aveva un posto di soccorso; in tal modo i Romani fino dall'anno 6 dopo
Cristo avevano adottato il decentramento dei servizi di soccorso per
ridurre al minimo lo spazio di tempo necessario per iniziare lo spegnimento
degli incendi.
Ogni coorte aveva 1000 uomini Vigiles dipendenti
da un Tribuno, da 7 Centurioni e da vari sottufficiali principales
con funzioni determinate.
Inoltre vi erano 4 medici e un certo numero di infermieri aides;
il Tribuno aveva un addetto alla sua persona secutor
e ogni Centurione poteva essere sostituito o aiutato da un graduato
optio.
In ogni coorte vi erano: i trombettieri (bucintores)
per dare i segnali gli specialisti per i servizi vari e cioè
gli addetti alle pompe e alle prese d'acqua (siphonarii
e aquari), i
portatori di materassi di salvataggio (emitularii),
gli addetti ai bagni (balneari), gli addetti
ai magazzini (horrearii), un alfiere (signifero
vexillarius) che portava il gagliardetto e un ministro
del culto (victimarius).
Per lo spegnimento degli incendi i Vigili avevano un materiale vario
costituito da pompe, sifoni, tubi di cuoi o di legno, recipienti per
l'acqua (hamac) secchi di  giunchi
spalmati di pece; pertiche (perticae) scale
(scalae), corde (funes),
copertoni (centones), sacchi di sabbia, pelli
di animali imbevute di acqua o di aceto o spalmate di vertiolo; materassi,
ramponi, martelli; zappe, seghe; roncole; ecc.
Inoltre dagli scritti di Vitruvio ci viene tramandata l’invenzione
di una macchina detta Antlia che serviva per mettere in pressione l’acqua
nei tubi permettendo di raggiungere anche i piani elevati. giunchi
spalmati di pece; pertiche (perticae) scale
(scalae), corde (funes),
copertoni (centones), sacchi di sabbia, pelli
di animali imbevute di acqua o di aceto o spalmate di vertiolo; materassi,
ramponi, martelli; zappe, seghe; roncole; ecc.
Inoltre dagli scritti di Vitruvio ci viene tramandata l’invenzione
di una macchina detta Antlia che serviva per mettere in pressione l’acqua
nei tubi permettendo di raggiungere anche i piani elevati.
L'Imperatore Claudio istituì
una VIII coorte di Vigili a Ostia, ove si ammirano ancora oggi i resti
di una vasta caserma presso il Teatro, con un distaccamento a Porto
per proteggere i grandi magazzini del Porto Claudio e della darsena
Traiana.
In seguito gli Imperatori estesero e migliorarono il numero delle coorti
si era elevato a 38 con 16.000 uomini.
Dai grafiti che esistono tuttora sui muri della caserma della VII coorte
al Viale del Re risulta che i vigili erano incaricati anche della pubblica
illuminazione fatta con fiaccole di sego (sebaciaro)
la cui origine rimonta probabilmente all'epoca dell'impero di Antonino
Caracalla (210-215 d.C.).
La Militia Vigilum seguì le sorti della
decadenza dell'impero specialmente dopo il trasporto della capitale
a Costantinopoli. |